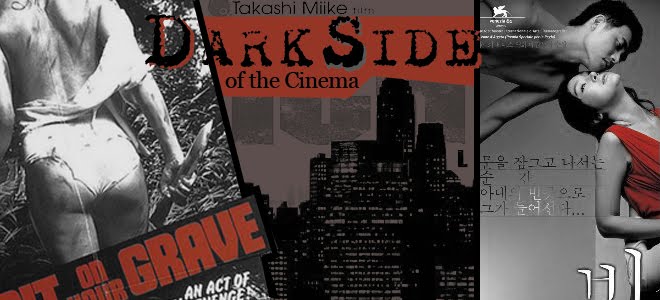Circa un mese fa stavo leggendo “La faccia nascosta della luna” il nuovo romanzo di Carlo Lucarelli in cui l'autore traccia “una mappa per orientarsi nella leggenda nera che accompagna la vita, e la morte, di tante star della musica e del cinema”. In questo libro vi sono resoconti dettagliati di tutti i casi più misteriosi accaduti nel mondo dello spettacolo: la morte di Kurt Cobain, quelle alquanto strane di Marylin Monroe e di Jim Morrison, quella di Brandon Lee avvenuta sul set de Il corvo (The Crow, 1994), quella più recente di Heath Ledger e tantissime altre che non sto qui ad elencarvi. Tra tutte queste – più o meno famose – morti misteriose ce n'è una che mi ha profondamente colpito, di cui avevo già sentito parlare, ma della quale non conoscevo i cruenti particolari: l'efferato omicidio di Elisabeth Ann Short, la quale sarà ricordata da tutti come “Black Dahlia”. Cosa mi ha colpito di questa storia? Prima di tutto l'efferatezza del delitto di cui è stata vittima la Dalia Nera: il corpo è stato ritrovato troncato in due parti, la ragazza è stata picchiata con ferocia ed era piena di lividi, le budella sono state estratte completamente, due tagli profondi allargavano la bocca fin sotto le orecchie, e per finire essa è stata sodomizzata dopo la morte. L'altro motivo di interesse era dato dal fatto che nel 1987, da questo fatto di cronaca, James Ellroy aveva tratto un romanzo intitolato “Black Dahlia” appunto. James Ellroy è l'autore di un libro, “L.A. Confidential”, da cui Curtis Hanson ha ripreso la sua omonima pellicola con Russel Crowe e Kevin Spacey. L.A. Confidential (Id., 1997) è uno dei miei film noir preferiti e quindi il passo successivo è stato semplice: mi sono procurato il libro e me lo sono divorato in pochissimi giorni. Essendo, come ormai avrete capito, un appassionato di cinema, il passo seguente è stato ancora più semplice, anzi direi istintivo: mi sono procurato il film che Brian De Palma aveva tratto dal libro nel 2006. Il problema è che se apprezzi, in maniera particolare, il libro – come ho fatto io in questo caso – stai pur certo che rimarrai deluso dalla sua trasposizione cinematografica. Purtroppo questa è quasi una legge non scritta.
Circa un mese fa stavo leggendo “La faccia nascosta della luna” il nuovo romanzo di Carlo Lucarelli in cui l'autore traccia “una mappa per orientarsi nella leggenda nera che accompagna la vita, e la morte, di tante star della musica e del cinema”. In questo libro vi sono resoconti dettagliati di tutti i casi più misteriosi accaduti nel mondo dello spettacolo: la morte di Kurt Cobain, quelle alquanto strane di Marylin Monroe e di Jim Morrison, quella di Brandon Lee avvenuta sul set de Il corvo (The Crow, 1994), quella più recente di Heath Ledger e tantissime altre che non sto qui ad elencarvi. Tra tutte queste – più o meno famose – morti misteriose ce n'è una che mi ha profondamente colpito, di cui avevo già sentito parlare, ma della quale non conoscevo i cruenti particolari: l'efferato omicidio di Elisabeth Ann Short, la quale sarà ricordata da tutti come “Black Dahlia”. Cosa mi ha colpito di questa storia? Prima di tutto l'efferatezza del delitto di cui è stata vittima la Dalia Nera: il corpo è stato ritrovato troncato in due parti, la ragazza è stata picchiata con ferocia ed era piena di lividi, le budella sono state estratte completamente, due tagli profondi allargavano la bocca fin sotto le orecchie, e per finire essa è stata sodomizzata dopo la morte. L'altro motivo di interesse era dato dal fatto che nel 1987, da questo fatto di cronaca, James Ellroy aveva tratto un romanzo intitolato “Black Dahlia” appunto. James Ellroy è l'autore di un libro, “L.A. Confidential”, da cui Curtis Hanson ha ripreso la sua omonima pellicola con Russel Crowe e Kevin Spacey. L.A. Confidential (Id., 1997) è uno dei miei film noir preferiti e quindi il passo successivo è stato semplice: mi sono procurato il libro e me lo sono divorato in pochissimi giorni. Essendo, come ormai avrete capito, un appassionato di cinema, il passo seguente è stato ancora più semplice, anzi direi istintivo: mi sono procurato il film che Brian De Palma aveva tratto dal libro nel 2006. Il problema è che se apprezzi, in maniera particolare, il libro – come ho fatto io in questo caso – stai pur certo che rimarrai deluso dalla sua trasposizione cinematografica. Purtroppo questa è quasi una legge non scritta.Brian De Palma è stato per anni uno dei miei registi preferiti. A farmi “innamorare” di questo autore americano sono stati soprattutto tre suoi “gangster movie” i quali a mio avviso sono la summa del genere negli ultimi trent'anni: Scarface (Id., 1983), Gli intoccabili (The Untouchables, 1987) e Carlito's way (Id., 1993). Nonostante queste tre “perle”, far coincidere la carriera di questo eclettico regista ad un solo determinato genere sarebbe sbagliato, perché Brian De Palma ha dimostrato, sin dai suoi esordi, di sapersi muovere con abilità in tutti i generi cinematografici: dall'horror con Carrie, lo sguardo di satana (Carrie, 1976), al thriller con Fury (Id., 1972) e Vestito per uccidere (Dressed to Kill, 1980) fino al cinema di guerra/denuncia con Vittime di guerra (Casualties of War, 1989). Ma dopo la carota, purtroppo c'è sempre il bastone... e siccome soffro a fare certe affermazioni, lo dirò in maniera veloce, ma non – ahimè – indolore: Brian De Palma non ne azzecca più una da quasi vent'anni, ovvero dal già citato Carlito's way. Dopo di esso, il regista del New Jersey ha diretto solo film mediocri come Mission: Impossible (Id., 1996), Omicidio in diretta (Snake Eyes, 1998), Mission to Mars (Id., 2000), Femme fatale (Id., 2002) e, anche la pellicola in questione, Black Dahlia (The Black Dahlia, 2006) non sfugge dal baratro dell'anonimato artistico in cui sembra essere caduto l'autore. Parrebbe però che Redacted (Id., 2007), la sua ultima fatica registica, sia tutt'altro che malaccio. Il film si basa su un fatto di cronaca, ovvero lo stupro di un'adolescente da parte di alcuni soldati americani in Iraq: purtroppo non avendolo visto non posso esprimere un parere a proposito, ma spero vivamente che il buon vecchio Brian possa, se non tornare ai fasti di un tempo, almeno rialzarsi dopo le ultime fragorose cadute.
Ecco brevemente la trama di Black Dahlia. Los Angeles 1947, Bucky Bleichert e Lee Blanchard, due ex pugili entrambi ora poliziotti, si ritrovano invischiati in uno dei più brutali omicidi mai avvenuti nella “città degli angeli”: quello di Elisabeth Ann Short, giovane ragazza arrivata, come tante altre, ad Hollywood in cerca di fortuna, la quale sarà soprannominata, per il suo modo di vestirsi – ma anche per la sua passione per il film La dalia azzurra (The Blue Dahlia, 1946) –, dai giornalisti la Dalia Nera.
Voglio essere chiaro sin dall'inizio, Black Dahlia non è pessimo ed, in confronto ai più recenti lavori del regista, rappresenta comunque una piccola risalita... diciamo un primo passo di una lunga riabilitazione. Però non posso neanche dire che mi è piaciuto, molto probabilmente se non avessi conosciuto il libro da cui è tratto, l'avrei apprezzato un po' di più, ma comunque rimarrebbe sempre un lavoro senza infamia e senza lode, con pochi pregi e molti difetti. Ma il vero problema è, appunto, il libro: se hai letto l'opera letteraria di James Ellroy non puoi accettare di buon grado il film di Brian De Palma a priori; non perché lo sceneggiatore Josh Friedman si prenda chissà quali libertà nell'adattare il romanzo per il cinema, ma perché la pellicola sembra un riassunto fatto male. Sono perfettamente consapevole che non è un'impresa facile trasformare un libro in una buona sceneggiatura, che qualche parte va assolutamente tagliata e che quello che funziona sulla carta non è detto che funzioni su uno schermo, perché linguaggio letterario e linguaggio filmico sono diversissimi ed hanno ognuno le proprie regole, però certe decisioni non me le riesco proprio a spiegare. Uno. L'opera di James Ellroy è ambientata a Los Angeles come il film, ma in quest'ultimo non c'è praticamente quasi nessun riferimento ad Hollywood. What?? Mi chiedo come possa essere possibile una scelta del genere, il romanzo è praticamente incentrato su questo mondo “malato... lussurioso... esagerato...” ma nella pellicola di ciò non vi è traccia. Ma non parlo solo della trama, in cui vi è solo qualche breve accenno al mondo del cinema, ma soprattutto della caratterizzazione ambientale: girare un film su Hollywood, o comunque ambientato in quel mondo, senza Hollywood è veramente un paradosso. Due. Eliminare completamente la sempre più crescente ossessione che il protagonista, Bucky Bleichert, ha nei confronti della Dalia Nera. A mio avviso errore imperdonabile, perché in pratica il romanzo è basato sue questo: su come un caso di cronaca, così efferato e sconcertante, e con protagonista una giovane donna bella e ammaliante, abbia sconvolto la vita di chi ne è rimasto invischiato. Il fatto è che nel film di Brian De Palma, per semplificare la narrazione, vengono eliminati quasi tutti i colleghi di Bucky e Lee, compresi i due Vogel – padre e figlio – che nel romanzo hanno un ruolo chiave: la soffiata che il protagonista fa nei loro confronti, che porterà all'arresto di uno e al suicidio dell'altro, è l'inizio del declino della carriera di Bucky Bleichert e della sua ossessione per la Dalia Nera. Inoltre, non vi è nessun accenno all'attrazione sessuale che prova il protagonista per Elisabeth Ann Short e che lo spinge tra le braccia dell'aristocratica Madeleine Sprague. Tre. L'eccessiva semplificazione di alcuni personaggi chiave, in primis, Lee Blanchard: nel film non si capisce perché egli è così sconvolto dall'omicidio Short, mentre nel libro la spiegazione c'è ed è l'omicidio della sorella di cui egli si sente responsabile. Stesso discorso per il suo rapporto con il criminale Bobby DeWitt, il quale viene a malapena accennato. Anche il personaggio di Kay Lake perde molto appeal nel passaggio da libro a pellicola, infatti in quest'ultima essa ha un ruolo del tutto marginale. Il problema qui è dettato dal fatto che nel film viene tagliata completamente la parte del matrimonio tra Kay e Bucky. Eliminando questo “blocco” di romanzo, praticamente colei che era una figura chiave dell'opera di Ellroy diventa una sorta di anonima comprimaria. Tra l'altro, altra nota stonata, il “triangolo non triangolo” tra i tre protagonisti (Bucky Bleichert, Lee Blanchard e Kay Lake) non sembra interessare minimamente Brian De Palma, il quale preferisce concentrarsi su altri eventi.
Veniamo ora alle note positive: per prima cosa le scenografie di Dante Ferretti; esse, pur essendo poco incentrate su Hollywood, sono veramente stupefacenti. Sembra veramente di essere tornati indietro nel tempo, all'interno di uno di quei noir classici che andavano tanto di voga negli anni cinquanta. Secondo punto, la fotografia di Vilmos Zsigmond giustamente cupa come deve essere la fotografia di un film del genere. Infine, la regia di Brian De Palma. Il regista del New Jersey avrà pure perso l'ispirazione, però con la macchina da presa ci sa veramente fare. Guardare la scena del ritrovamento del cadavere per convincersi di ciò.
Ultima nota sugli attori. Onestamente la scelta del cast non mi sembra troppo azzeccata: Josh Hartnett, oltre ad avere qualche dubbio sulle sue capacità attoriali, è troppo bello per la parte di Bucky Bleichert, che nel libro viene descritto come una persona buffa per colpa di due “dentoni”; Aaron Eckahrt non riesce a dare spessore al personaggio di Lee Blanchard, ma in questo caso forse la colpa è anche della sceneggiatura; Scarlett Johansson – Kay Lake - è a mio avviso completamente fuori ruolo; va un po' meglio con Hilary Swank nella parte di Madeleine Sprague, ma sinceramente da un'attrice vincitrice di due premi Oscar ci si può aspettare di più. Conclusione: Black Movie.