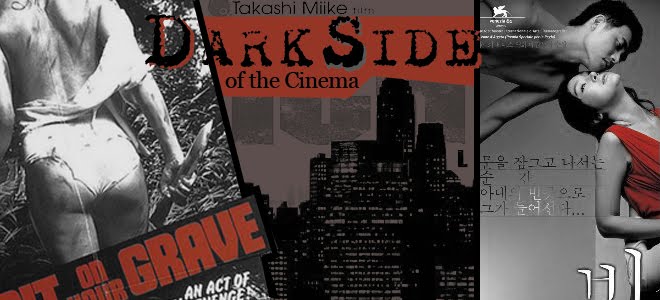Nuova chicca orientale per i miei fidati lettori... e questa volta il caso è ancora più eclatante e sconcertante del precedente, ovvero Conduct Zero (Pumhaeng Zero, 2002) di Cho Keun-Sik. Almeno la pellicola da me trattata in precedenza aveva visto la luce, nel nostro bel paese, in un edizione dvd scarna... la quale non comprendeva neanche l'audio in italiano, ma solo quello originale con i sottotitoli nella nostra lingua opzionabili. A Bungee Jumping of Their Own (Beonjijeompeureul hada, 2001) di Kim Dae-sung è andata sicuramente peggio: esso non è mai uscito qui da noi e non credo, a questo punto, che uscirà mai. Peccato, perché è veramente un bel film! Qui si potrebbe, e sarebbe molto interessante, aprire un dibattito sulle scelte dei film da distribuire da parte delle case di produzione e distribuzione di audiovisivi: esse sono sicuramente condizionate dalle leggi del mercato, se no non si spiegherebbe l'uscita di film come American Pie 12, 13, 14... o di altri “filmacci” del genere a discapito di pellicole sicuramente più valide ma con poco appeal sullo spettatore medio. Per quanto riguarda il cinema asiatico, mi vengono in mente subito due commedie mai uscite in Italia... diciamo da consigliarvi così su due piedi: I'm Cyborg, But That's Ok (Saibogujiman kwenchana, 2006) di Park Chan-Wook mitico regista della “trilogia della Vendetta” comprendente Sympathy for Mr. Vengeance (Boksuneun naui geot, 2002), Old Boy (Oldebuoi, 2003) e Lady Vendetta (Chinjeolhan geumjassi, 2005); l'altra pellicola andata misteriosamente perduta invece è My Sassy Girl (Yeopgijeogin geunyeo, 2001) di Jae-young Kwak... che non è cinema, ma è IL cinema.
Nuova chicca orientale per i miei fidati lettori... e questa volta il caso è ancora più eclatante e sconcertante del precedente, ovvero Conduct Zero (Pumhaeng Zero, 2002) di Cho Keun-Sik. Almeno la pellicola da me trattata in precedenza aveva visto la luce, nel nostro bel paese, in un edizione dvd scarna... la quale non comprendeva neanche l'audio in italiano, ma solo quello originale con i sottotitoli nella nostra lingua opzionabili. A Bungee Jumping of Their Own (Beonjijeompeureul hada, 2001) di Kim Dae-sung è andata sicuramente peggio: esso non è mai uscito qui da noi e non credo, a questo punto, che uscirà mai. Peccato, perché è veramente un bel film! Qui si potrebbe, e sarebbe molto interessante, aprire un dibattito sulle scelte dei film da distribuire da parte delle case di produzione e distribuzione di audiovisivi: esse sono sicuramente condizionate dalle leggi del mercato, se no non si spiegherebbe l'uscita di film come American Pie 12, 13, 14... o di altri “filmacci” del genere a discapito di pellicole sicuramente più valide ma con poco appeal sullo spettatore medio. Per quanto riguarda il cinema asiatico, mi vengono in mente subito due commedie mai uscite in Italia... diciamo da consigliarvi così su due piedi: I'm Cyborg, But That's Ok (Saibogujiman kwenchana, 2006) di Park Chan-Wook mitico regista della “trilogia della Vendetta” comprendente Sympathy for Mr. Vengeance (Boksuneun naui geot, 2002), Old Boy (Oldebuoi, 2003) e Lady Vendetta (Chinjeolhan geumjassi, 2005); l'altra pellicola andata misteriosamente perduta invece è My Sassy Girl (Yeopgijeogin geunyeo, 2001) di Jae-young Kwak... che non è cinema, ma è IL cinema.Bungee Jumping of Their Own è stato il film d'esordio del regista coreano Kim Dae-sung, il quale fu, in precedenza, assistente alla regia del maestro Im Kwon Taek. Questa sua pellicola è stata definita da molti critici come il più raffinato mèlo del cinema coreano contemporaneo, questo per farvi capire che non si tratta proprio di un filmetto qualunque, il che rende ancora più assurdo il suo esilio forzato dal nostro, cinematograficamente parlando, ignorante paese.
Agosto 1983. In un piovoso pomeriggio In-woo, timido studente universitario, incontra alla fermata del bus la bellissima Tae-hee, studentessa d'arte. Tra di loro nasce ben presto un legame profondissimo, ostacolato però dall'incombente servizio militare che aspetta In-woo. Il film poi esegue un salto temporale in avanti di quasi vent'anni e nel 2000 ritroviamo In-woo sposato, con un altra donna, e professore in un rinomato liceo. Sarà proprio in questo liceo che In-woo si innamorerà di un suo studente diciassettenne, il quale a suo parere, altro non è che la reincarnazione di Tae-hee, il suo primo – e unico – grande amore.
Bungee Jumping of Their Own è una pellicola caratterizzata da una struttura bipolare. Dopo un inizio folgorante, che solo a visione conclusa si potrà comprendere appieno, con la telecamera che vola tra uno splendido paesaggio, la prima parte del film risulta essere una commedia romantica che ha per protagonisti due giovani studenti innamorati alle prese con i classici problemi del primo amore. Quello che mi ha colpito di questo segmento di film è la delicatezza con cui il regista tratta argomenti importanti come la prima volta: le difficoltà sono ben rappresentate dalla scena clou di questa prima parte in cui, In-woo e Tae-hee desiderosi di perdere la loro verginità insieme, si recano in uno squallido motel. Una volta giunti a destinazione, i due ragazzi se ne stanno tutta la notte uno da una parte della stanza e l’altra dalla parte opposta senza avere nessuno dei due il coraggio di fare il primo passo. La realizzazione di questo primo “spezzone” di film è di impianto molto classico e non spicca per originalità: vi sono le solite schermaglie iniziali, con la protagonista restia a concedersi all’amore dello spasimante; vi sono i soliti amici che spingono il protagonista verso la tanto agognata “prima volta” recando ad esso più danno che altro; e vi sono le solite situazioni ambigue e controverse che rischiano di incrinare il rapporto. Certo è innegabile che Kim Dae-sung ha un grandissimo talento e, proprio per questo, pur confrontandosi con un inizio di pellicola molto standardizzato, riesce ad elevarsi dalla media grazie a sequenze molto ben realizzate come quella del litigio sotto la pioggia. Ma Bungee Jumpinf of Their Own prende letteralmente il volo nella sua seconda parte facendo salire di livello una pellicola fino ad allora solo appena godibile. Primo tocco di genio del regista: stacco di quasi vent’anni – dal 1983 al 2000 – improvviso, inaspettato e senza una minima spiegazione. La seconda metà del film è un sublime dramma intimistico incentrato su un argomento che è ancora tabù in Corea del Sud, ovvero l’omosessualità: in tale paese questa tendenza sessuale è rinnegata almeno quanto da noi Berlusconi sconfessa il potere dei giudici. Infatti è molto difficile che si realizzano film su tale scottante argomento e dei pochi realizzati quello in questione è, forse, l’unico ad aver riscontrato successo e consensi. Tra l’altro pensate che in Corea del Sud vi è perfino un test per poter testare la virilità maschile e quindi provare la propria non omosessualità... lo stesso protagonista del film in questione si sottopone a tale test. Questo secondo tempo segue In-woo ormai adulto e la sua crescente passione per un suo studente, nel quale il protagonista vede la reincarnazione del suo primo grande amore. La pellicola di Kim Dae-sung cambia così totalmente regime tralasciando i toni leggeri e spensierati della prima parte e concentrandosi sulla lenta ed inesorabile devastazione della vita del protagonista che lo porterà a perdere prima il lavoro e poi la moglie, forse in realtà mai amata veramente. Pur accostandosi al tema dell’omosessualità, splendidamente messo in scena nella seconda parte, il vero scopo del regista è quello di realizzare una pellicola sull’amore eterno, il quale non può essere limitato da niente e da nessuno… l’amore vero, quello infinito, quello che prosegue anche oltre la morte. Detto così sembra molto banale, ma non lo è assolutamente, credetemi: Bungee Jumping of Their Own è una parabola sul destino, su quello che esso ci toglie e su quello che poi ci ridà. Il primo amore inizialmente rubato ad In-woo, adesso gli viene restituito, e poco importa sotto quale aspetto o forma. Tae-hee è – forse… – rinata nelle spoglie di Hyun-bin, un giovane studente diciassettenne, ma questo non sembra interessare al protagonista, il quale non riesce a resistere al richiamo del vero amore: “Se ti gettassi da un precipizio, dicevi che la tua vita non sarebbe finita lì. Ci incontreremo di nuovo, innamorandoci. Non sarà solo perché ti amo, ma perché l’unica cosa che posso fare è amarti, amarti per sempre”.
Il film di Kim Dae-sung è veramente una pellicola stranissima, che consiglio vivamente a tutti. Certo non è esente da pecche e qua e la c’è qualche piccolo tonfo nella sceneggiatura… però il regista riesce a tenere bene in mano la situazione equilibrando un lavoro formato praticamente da due metà che poco hanno in comune, infatti ad un primo spezzone scanzonato ne segue uno molto drammatico. A mio parere, questa seconda parte è nettamente superiore alla prima, anche perché quest’ultima, alla fine, sa troppo di già visto. Se dovessi trovare una pecca a tutti i costi, direi che gli amici del protagonista da studente sono troppo stereotipizzati: in pratica sono solo due, uno naturalmente pensa solo al sesso, l’altro invece è più saggio e prudente. Insomma, la solita solfa della coscienza divisa: se ci fate caso infatti in molti film – soprattutto commedie – le spalle (ovvero i co-protagonisti) del personaggio principale hanno sempre la personalità agli antipodi, da una parte si ha l’amico “diavoletto” che naturalmente consiglia sempre male e altrettanto naturalmente viene sempre ascoltato dal protagonista, se no non si potrebbe avere la classica crisi pre-conciliazione finale tra i due attori principali, mentre dall’altra si ha, invece, l’amico “angioletto”, quello che ovviamente non viene mai preso in considerazione. Nella seconda parte, mi ha molto convinto la rappresentazione della presunta omosessualità crescente del protagonista. Povia in una sua – pessima… – canzone cantava: “Luca era gay, ma adesso sta con lei…”, in Bungee Jumping of Their Own è vero invece il contrario: “In-woo stava con lei, ma adesso invece è gay…”, anche se questo è tecnicamente inesatto. In-woo non è omosessuale, egli è innamorato di Tae-hee che si è reincarnata in un ragazzo, e questo non è mica colpa sua… d’altra parte al vero amore non si comanda.
Per concludere, una nota di merito al finale della pellicola che mi ha molto colpito e affascinato. È vero che esso forse è un po’ forzato e, a ben vedere, anche un po’ scontato però raggiunge vette di poeticità e lirismo che ultimamente difficilmente mi è capitato di riscontrare in altri film. Se dovessi far un paragone lo affiancherei alla conclusione di Ferro 3 – la casa vuota (Bin Jin 3 - Iron, 2004) di Kim Ki-Duk… alt! Chi non ha visto questo film è pregato di smettere di leggere e di andare subito a noleggiarlo, pena fustigazione con cinghia di cuoio. Mi trovo d’accordo con Paolo Mereghetti che a proposito della fine di Ferro 3 – la casa vuota ha scritto: “il finale sarebbe piaciuto ai surrealisti”. Verissimo, ne approfitto per utilizzare questa citazione per il film in questione, anche questo finale sarebbe piaciuto molto ai surrealisti… il motivo?! Lo stesso che ci dà sempre il buon Mereghetti nel suo dizionario riferendosi alla pellicola di Kim Ki-Duk: l’elogio dell’amore più forte di tutto, persino della logica, Conclusione: è l’amore, non la ragione, che è più forte della morte (Thomas Mann).